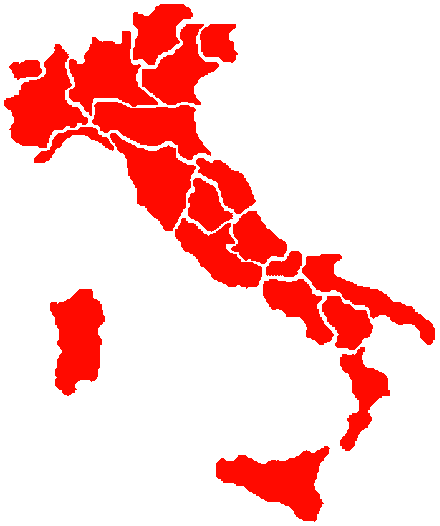La rivolta social della Gen Z in Nepal: un segnale anche agli operatori privacy
È accaduto in Nepal, non certo in Russia o in Cina, dove il potere di controllo sui social è esercitato da anni con strumenti algoritmici e apparati repressivi capillari. A Kathmandu, invece, la mancanza di filtri e di sistemi di contenimento ha fatto esplodere la rivolta.

La decisione del governo di oscurare ventisei piattaforme e, di colpo e migliaia di giovani in piazza. Non soltanto perché volevano tornare a chattare o condividere video, ma perché si sono visti sottrarre l’unico spazio pubblico di confronto e di identità. E, forse, anche un po’ di gioco.
In Nepal sì; in Iran o Afghanistan (per ora) no.
Gli Stati hanno già compreso il potere dei social: possono essere veicolo di democrazia o strumento di repressione, a seconda di chi ne governa l’accesso. Non è un caso che anni fa un tribunale italiano li avesse considerati un luogo essenziale e indispensabile del dibattito politico, riconoscendo che la cittadinanza e i diritti connessi oggi si esercitano anche online e, in particolare, in spazi dove possiamo esprimerci.
Accessi e modalità di utilizzo passano comunque attraverso grandi operatori privati e, non dimentichiamolo, sotto forma di contratto con l’utente.
Ma cosa chiedono davvero i giovani nepalesi? In superficie hanno chiesto di riaprire Facebook, Instagram, YouTube. È stata la miccia. Ma in realtà, dietro quella richiesta immediata, c’è un’urgenza più profonda: poter contare, avere voce in un sistema che percepiscono chiuso, corrotto e dominato dal nepotismo.
Il dubbio resta: cercavano libertà di opinione e parola, o solo la possibilità di tornare a giocare e a intrattenersi? Forse entrambe le cose. Perché per la Gen Z, oggi, il confine tra spazio di svago e spazio politico è labile: si discute nei commenti sotto un video, si organizzano cortei su TikTok, si denunciano ingiustizie in una diretta Instagram. O vogliamo dimenticare che per molti è l'unico contatto con il resto del mondo.
Ed è proprio qui che si gioca la partita: se la piazza digitale viene vista solo come intrattenimento, il controllo sarà facile da esercitare e altrettanto facile da giustificare. Ma se inizia a prevalere l’uso consapevole e massivo dei social come strumenti di attivismo e coscienza sociale, allora anche altri governi dovranno ripensare il loro rapporto con queste piattaforme. E lo faranno.
(Nella foto: l'Avv. Gianni Dell'Aiuto)
In questo complesso, e non certo ipotetico e futuribile scenario, gli operatori della privacy non possono limitarsi a interpretare regolamenti e ad archiviare consensi. O eseguire passivamente ordini.
Sono i primi guardiani delle modalità di accesso, della qualità del trattamento dei dati e della neutralità degli spazi digitali. Se accettano senza vigilanza che siano le piattaforme a decidere chi entra, come entra e cosa può dire, il rischio è di diventare senza volerlo, e in buona fede, complici di chi, un prossimo domani, potrà chiudere la piazza digitale o, peggio ancora, manipolare i dati per un proprio fine personale; economico o politico esso sia.
Già negli anni ’80 Alvin Toffler aveva intuito che il mondo digitale avrebbe diviso le persone in due grandi categorie: i prosumer, capaci di produrre e consumare contenuti, e la massa dei semplici spettatori. Poco dopo Neil Postman ci avvertiva che non tutti hanno lo stesso peso nel discorso pubblico: c’è chi lo plasma e chi lo subisce, con il rischio che l’intrattenimento prevalga sulla sostanza. Con l’avvento delle piattaforme, Clay Shirky ha mostrato come la dinamica si sia accentuata: pochi guidano la conversazione, mentre la maggioranza resta una “silent audience”. Più di recente, Evgeny Morozov e Shoshana Zuboff hanno svelato il rovescio della medaglia: non sono solo gli utenti a produrre o a consumare, ma sono le big tech a decidere cosa vediamo, trasformando miliardi di persone in semplici scrollatori di un flusso che non controllano. Scenari orwelliani.
La rivolta in Nepal, con tutte le sue contraddizioni, ci consegna quindi un segnale chiaro: non è più possibile distinguere tra protezione dei dati e protezione delle libertà fondamentali. In un mondo dove le piazze reali si svuotano e quelle digitali diventano il centro del dibattito, la responsabilità dei professionisti della privacy è anche quella di custodire la soglia tra accesso e censura.
Non si tratta soltanto di compilare informative o aggiornare registri: dietro ogni scelta tecnica, dietro ogni consenso spuntato, c’è la possibilità di rafforzare o di indebolire diritti: primo, quello alla parola. In Nepal lo abbiamo visto in forma esplosiva, ma la stessa dinamica può aleggiare ovunque: basta un algoritmo che silenzia, una piattaforma che decide, un governo che chiude.
È lì che la privacy smette di essere un adempimento e diventa difesa della cittadinanza non solo digitale.