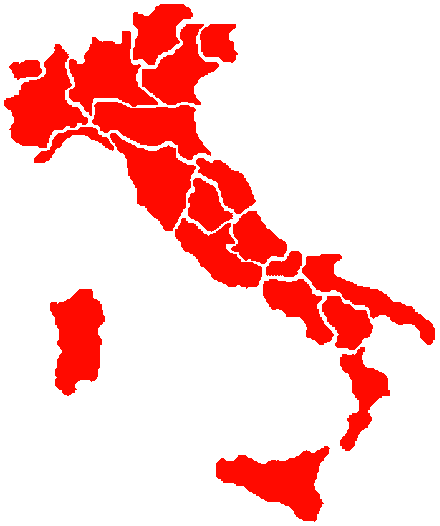L'ingresso dell'intelligenza artificiale in azienda? dalla porta principale, con adeguato set di regole
Non può sfuggire la rilevanza dell'indagine condotta da Ivanti (società USA con sede a Salt Lake City, Utah) su oltre 6.000 impiegati e 1.200 professionisti IT (di cui dà conto il rapporto "2025 Technology at Work: Reshaping Flexible Work", indagine di cui questo sito ha tempestivamente riportato la notizia), stando alla quale il 32% dei dipendenti ricorre a sistemi di AI generativa all'insaputa del proprio datore di lavoro.
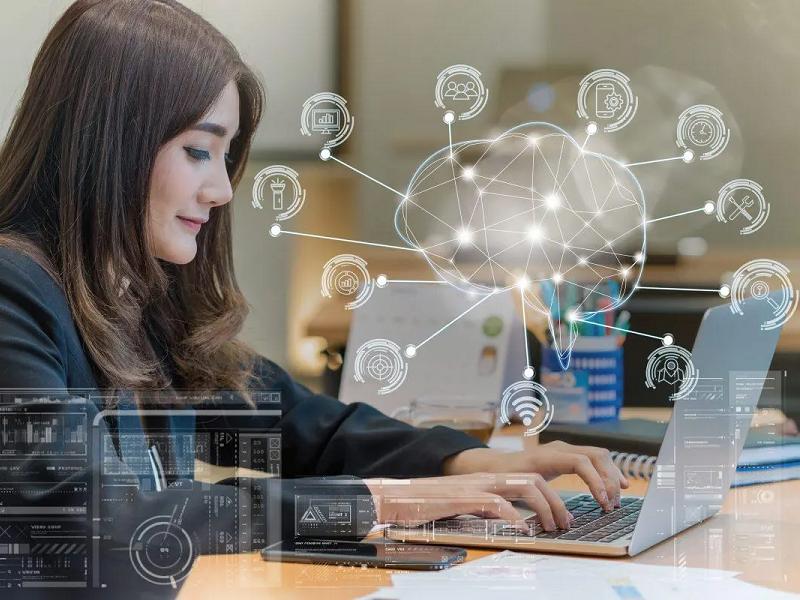
A parte i moventi delle condotte e le condotte stesse - sicuramente meritevoli di analisi, valutazioni, misure e attenzioni meditate -, che interpellano varie tipologie di operatori (responsabili risorse umane, rappresentanti sindacali dei lavoratori, formatori, psicologi, sociologi, giuristi, ecc.), la particolarità (non la novità) offerta dall'indagine è, in un certo senso, il punto di vista. Il dibattito sulle nuove tecnologie, infatti, risulta più spesso concentrato sulle opportunità che esse rappresentano per le aziende in termini di incrementi di efficienza/produttività e sui rischi che dischiudono quanto a possibili interferenze/compressioni dei diritti dei prestatori di lavoro.
Stavolta, per l'appunto, sono proprio i lavoratori che assurgono a protagonisti immediati del discorso: protagonisti malintesi però, operanti nell'ombra; agenti inesperti e/o inconsapevoli, talora impauriti, del tutto scoordinati; quindi, anche non volendo, pericolosi.
L'utilizzo di software di AI nell'organizzazione, quando non riconducibile a decisioni corrette, può essere causa di perdite (di controllo) di dati personali, di violazioni dei diritti di autore, di rilasci di procedure e di know how altamente riservati, senza esclusione di altri pregiudizi.
Il problema è che l'AI dovrebbe essere gestita, non subita.
Il risultato del sondaggio suona come una sveglia, un po' drammatica. Il fatto che sistemi di AI generativa da tempo siano offerti sul mercato e disponibili al grande pubblico in forma gratuita o a prezzi abbordabili, con diffusione massiva del loro utilizzo, avrebbe già dovuto portare le organizzazioni, dinanzi a vari possibili scenari, in una situazione di pre-allarme.
Torna puntualmente in auge la responsabilità del datore di lavoro e titolare dei trattamenti, che dovrebbe intestarsi il problema del rapporto a tutto campo da instaurare con l'AI, considerato che l'unica scelta davvero inopportuna, se non del tutto implausibile, sarebbe il rifiuto pregiudiziale di un qualsivoglia rapporto. Il perché lo lascia intravedere proprio il sondaggio Ivanti: una decisione aprioristica e sommaria di chiusura integrale e/o di messa alla porta della AI può/potrebbe paradossalmente favorire comportamenti idonei a farla rientrare, abusivamente, inavvertitamente, dalla finestra.
Urge che il tema degli utilizzi dei sistemi di AI entri a pieno titolo nella riflessione datoriale e, ove necessario, nella dialettica aziendale. Per 'dialettica aziendale' si intende l'interazione tra datore e rappresentanze dei lavoratori. Il riferimento presuppone che il sindacato assuma un ruolo attivo, di stimolo alla riflessione sulla implementazione di soluzioni tecnologiche innovative, onde con gli impieghi/utilizzi appropriati si stabiliscano e si raggiungano obiettivi diversi ma convergenti: lo sviluppo aziendale, l'innalzamento della qualità dei processi, della produttività, certo; ma anche la crescita professionale dei collaboratori, il miglioramento del clima interno, la gratificazione non solo economica dei lavoratori.
Tutto questo naturalmente non può essere perseguito né conseguito al prezzo di prassi discutibili – per quanto socialmente diffuse, accettate o date per buone - ovvero di violazioni più o meno lampanti e/o gravi di requisiti posti a presidio della libertà e dignità delle persone così come a salvaguardia delle imprese.
Ecco, da queste premesse nasce l'esigenza di mettere in fila, senza pretesa di esaustività, una serie di questioni che scaturiscono dall'intendimento di ricorrere a sistemi di intelligenza artificiale per implementarli nell'organizzazione:
1. definizione delle aree/funzioni aziendali che dovrebbero/potrebbero giovarsi dell'utilizzo di sistemi di AI;
2. fissazione dei requisiti che i software di AI dovrebbero rispettare affinché il loro utilizzo fosse associato alle attività delle aree/funzioni aziendali prescelte;
3. selezione e acquisizione dei software in funzione delle performance desiderate ed in relazione a precise caratteristiche/garanzie di sicurezza, di riservatezza, di controllo delle destinazioni dei flussi di informazioni;
4. redazione e approvazione di norme aziendali per la disciplina dell'utilizzo dei software/sistemi di AI adottati dall'organizzazione, comprendenti obblighi e divieti la cui violazione sia sanzionata in conformità al codice disciplinare;
5. inserimento delle succitate norme nel regolamento interno relativo all'utilizzo degli strumenti di lavoro ed affissione ex art. 7, l. 300/1970;
6. formalizzazione di istruzioni operative ai dipendenti distinte per aree/funzioni, con particolare enfasi sugli impieghi proficui e sulle procedure corrette, sui comportamenti vietati e sulle modalità di controllo/verifica del rispetto delle prescrizioni;
7. interventi periodici di formazione e informazione degli addetti, anche in virtù e per la condivisione delle esperienze via via acquisite;
8. pianificazione di audit di prima parte sull'utilizzo dei software/sistemi di AI e sulla conformità delle attività svolte alle regole stabilite dall'impresa.
E' certo che mancano e si aggiungeranno molteplici spunti di riflessione, evidenze di criticità, ipotesi di ulteriori interventi/scelte operative.
La conclusione è che nel frattempo gli imprenditori, datori di lavoro e titolari dei trattamenti, non dovrebbero presumere che la diffusione crescente dell'intelligenza artificiale non abbia impatti sulle proprie organizzazioni, neppure quando la ritenessero ancora al di fuori dei 'cancelli' aziendali; neppure o, forse, a maggior ragione se decidessero di trattare l'AI come un frutto proibito, inavvicinabile, della contemporaneità, e di restarne alla larga.